Ambiente
L’altra faccia dell’Etna: la cenere vulcanica tra risorsa e rischio – Parte Seconda

Continua l’approfondimento sulle ceneri dell’Etna.
Dopo aver parlato della loro formazione e composizione, vediamo ora quali sono gli effetti sull’ambiente e sulla salute dell’uomo.
Quali sono gli effetti positivi delle ceneri vulcaniche sull’ambiente? Una volta che le ceneri ricadono sulla superficie terrestre, esse rilasciano gli elementi chimici contenuti. Questi, disciolti dall’acqua meteorica, vengono portati nel sottosuolo, cioè nelle falde acquifere. Molti di questi elementi sono ottimi nutrienti per il suolo e per le piante. Fungono infatti da fertilizzanti naturali, molto importanti per l’ecosistema, e rendono i terreni dell’Etna tra i migliori in Italia per le attività agricole. Gli elementi che raggiungono le acque di falda risultano inoltre benefiche per l’organismo in quanto apportano gli elementi minerali ottimali per il nostro ciclo biologico.
Uno studio del 2013 ha anche dimostrato che la cenere che cade in mare ha effetti molto positivi sullo sviluppo della vita marina. L’analisi della composizione chimica delle acque dello Ionio ha, infatti, dimostrato che a sud-est dell’Etna il mare è in condizioni di grande ricchezza di nutrienti e che, in alcune aree, raggiunge condizioni tali di eutrofizzazione da stimolare lo sviluppo degli organismi marini.
Ma come succede sempre per le cose più belle, bisogna fare i conti anche con l’altra faccia della medaglia. La cenere vulcanica può avere, infatti, anche risvolti molto negativi. E questi riguardano proprio la salute dell’uomo.
Quali possono essere, quindi, i potenziali rischi per la salute dell’uomo?
Partiamo da un dato: negli ultimi 20 anni nelle aree intorno all’Etna si è osservato un lieve ma significativo aumento di alcune patologie neurodegenerative e tumorali. Queste hanno una incidenze statisticamente superiore rispetto al resto della Sicilia e dell’Italia. Molti sono gli studi scientifici che purtroppo lo confermano, ma vogliamo qui riportarvi l’ultimo in ordine di tempo: Boumediene et alii 2019 “Amyotrophic lateral sclerosis spatial epidemiology in the Mount Etna region, Italy. European Journal of Neuroloy“.
Le malattie che hanno fatto riscontrare una maggiore incidenza sono la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e la sclerosi multipla (SM), seguita da tumori a tiroide, polmoni e sangue. Gli studi hanno dimostrato una correlazione spazio-temporale tra zone a maggiore incidenza delle malattie e loro posizione rispetto al vulcano (soprattutto fianco sud-orientale, quello esposto sottovento rispetto ai crateri sommitali e alle loro nubi eruttive).
Ma come fanno le ceneri vulcaniche ad entrare nell’organismo umano e innescare le malattie?
Un recente studio scientifico ha dimostrato che anche piccole quantità di ceneri e lapilli a terra con il continuo passaggio dei veicoli ne produce la frantumazione meccanica con formazione e successiva sospensione nell’aria delle così dette particelle PM10 (cioè con diametro inferiore o uguale a 10 micron). Tali particelle producono un potenziale pericolo per la salute umana, soprattutto per chi ha problemi respiratori o soffre di asma. Bisogna prestare molta attenzione anche quando si rimuove la cenere dalle proprie abitazioni: l’operazione dovrebbe sempre essere eseguita indossando una mascherina, per evitare di inalare le particelle vulcaniche più fini.
Anche l’inalazione prolungata delle particelle più fini, quelle cioè sospese naturalmente nell’aria dopo un evento parossistico, può portare all’assorbimento di metalli pesanti trasportati dalla cenere, che entrano così in circolo nel nostro sistema vascolare e linfatico.
Il meccanismo con cui agiscono non è in realtà ancora chiarissimo, ma sembra che lo stress ossidativo scatenato da alcuni metalli possa avere un ruolo importante nella patogenesi di alcune malattie neurodegenerative.
Concludiamo ora con una curiosità. Sapete che le ceneri vulcaniche se cadono sul suolo pubblico devono essere smaltite dalle amministrazioni locali come rifiuto speciale mentre se cadono sul suolo privato possono essere tranquillamente riutilizzate a piacimento? Una voragine legislativa che attende solo di essere sanata.
(Credit immagine: Ansa)
(Informazioni scientifiche tratte da vari studi e scritti dei ricercatori Daniele Andronico e Salvatore Giammanco dell’INGV di Catania, osservatorio etneo)
Giuliana Raffaelli
Ambiente
Pantelleria, sospensione pagamenti e blocco morosità per utenze idriche

Ciclone Harry – Misure straordinarie per gli utenti del Servizio Idrico. I dettagli
A seguito della Deliberazione del 09.02.2026 n. 20/2026/R/COM l’ARERA ha introdotto misure straordinarie a sostegno degli utenti del Servizio Idrico Integrato (SII) situati nei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici eccezionali dal 18 gennaio 2026.
Per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle utenze interessate il termine è fissato entro e non oltre il 30 aprile 2026.
Per maggiori dettagli si invita alla consultazione il comunicato dell’Ufficio Idrico
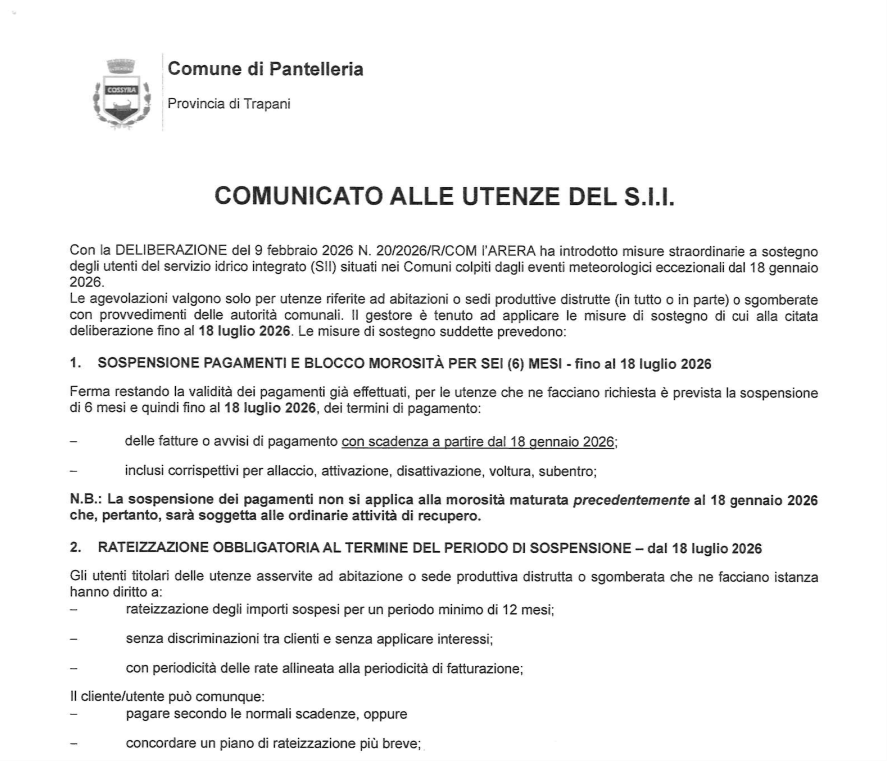
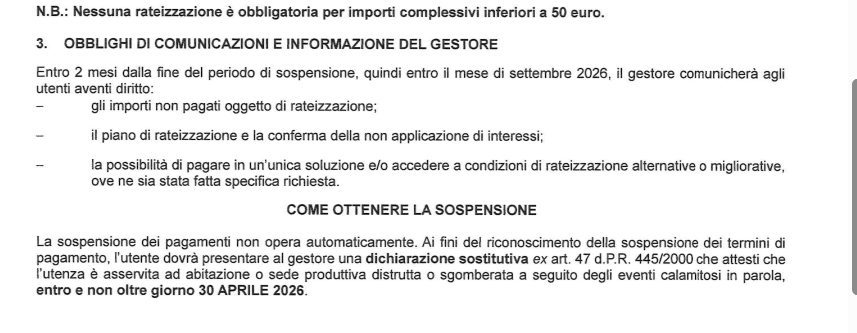
Resta informato con il nostro canale WhatsApp
Ambiente
Pantelleria, 24 e 25 febbraio senza luce. Ecco dove

Si rende noto che per inderogabili necessità di servizio
dalle ore 08.30 alle ore 13.30
di Martedì 24 Febbraio 2026
Verrà sospesa l’erogazione dell’energia elettrica nelle seguenti zone:
• Madonna delle Grazie SP 54
• Suvaki
• Euterpini
• Via Mannera
dalle ore 08.30 alle ore 13.30
di Mercoledì 25 Febbraio 2026
Verrà sospesa l’erogazione dell’energia elettrica nelle seguenti zone:
• Kania
• Punta Formaggio
• Via dei Margetti
• Dietro Isola
• Martingana
• Balata dei Turchi
• Salto della Vecchia
• Via dei Coloni
• Rekale bassa
• Nikà
Resta aggiornato con il nostro canale WhatsApp
Ambiente
A Pantelleria torna l’esperto di agricoltura bio-naturale Luigi Rotondo dal 3 marzo. Ecco come contattarlo

Dopo il grande successo e seguito ottenuto nelle sue lezioni di Agricoltura Bio-Naturale, realizzate con il Centro Culturale Giamporcaro, dal 3 marzo torna a Pantelleria Luigi Rotondo.

Con le sue doti didattiche, l’esperto era stato molto apprezzato sull’isola anche dalle persone più esigenti e preparate nel campo dell’agricoltura.
Luigi Rotondo durante gli incontri suggeriva metodi naturali o espedienti per fronteggiare parassiti e altre piccole o grandi esigenze delle colture.
Pantelleria e la sua agricoltura gli sono rimasti vicini e ha imparato a conoscerli bene, e così, in occasione di un suo ritorno sull’isola, si rende disponibile di quanti abbiano bisogno di una sua consulenza o consiglio.
Ecco come contattarlo direttamente: +39 324 828 8898.
Resta aggiornato con il canale WhatsApp
-

 Ambiente5 anni fa
Ambiente5 anni faAMP, a Pantelleria Insieme Live: zonizzazioni e Guardia Costa ausiliario. Gadir e il brillamento de Il Caldo
-

 Personaggi4 anni fa
Personaggi4 anni faStasera 4 Ristoranti a Pantelleria, con Alessandro Borghese. Ecco chi sono
-

 Ambiente4 anni fa
Ambiente4 anni faPantelleria, il PD segnala colorazione anomala e artificiale nella spiaggia del Lago di Venere
-

 Pantelleria4 anni fa
Pantelleria4 anni faPantelleria a lutto per Giovanni Maddalena, il galantuomo del Conitro
-
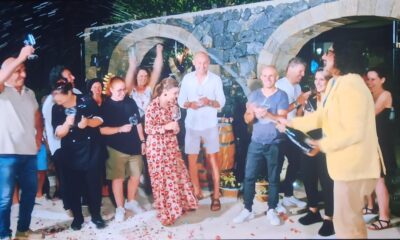
 Personaggi4 anni fa
Personaggi4 anni faPantelleria, è U Runcune il vincitore di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese
-

 Cronaca4 anni fa
Cronaca4 anni faUltima Ora – Pantelleria. Identificata la donna morta per annegamento, il secondo suicidio in un mese
-

 Capitaneria di Porto4 anni fa
Capitaneria di Porto4 anni faPantelleria, allarmanti condizioni meteo-marine nelle prossime 48/72 ore: onde 6 da metri
-

 Pantelleria4 anni fa
Pantelleria4 anni faPantelleria, divieto di balneazione a Punta San Leonardo

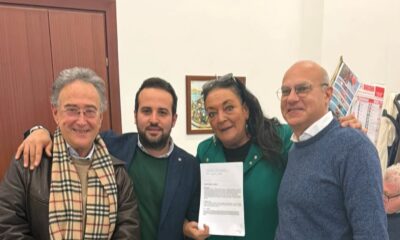









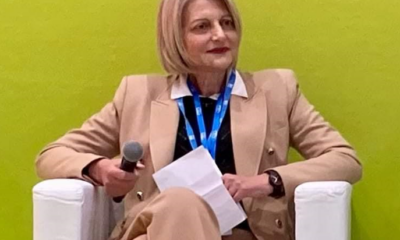









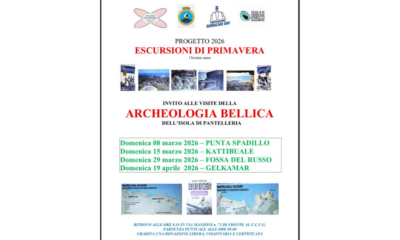














Cosentino Giuseppe
09:44 - Marzo 21, 2022 at 09:44
Buongiorno Dottoressa Raffaelli, complimenti per l’articolo. Abbiamo presentato riconoscimento DOP oliva nocellara etnea. In merito alle ceneri vulcaniche la Regione Siciliana ci ha posto un quesito: le ceneri vulcaniche fanno male all’agricoltura? e i metalli pesanti vengono assorbiti dalla pianta? Ci può dare chiarimenti? Grazie