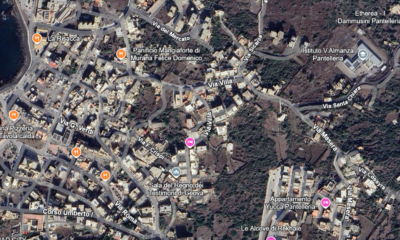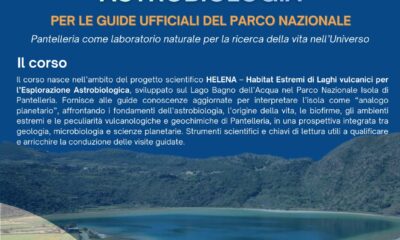Cultura
Ragusa, l’odore delle fave e nonno Turiddu

UN RICORDO… l’ODORE DI FAVE IN UNA SERATA DI MAGGIO IN SICILIA IN COMPAGNIA DI MIO NONNO TURIDDU…
E quando trovo il coraggio di raccontarla, la mia storia, tutto cambia. Perché nel momento stesso in cui la mia vita si fa racconto, il buio si fa luce e la luce mi indica una strada. E adesso lo so, il posto caldo, il posto al sud sono io… ciò mi rende sereno, almeno per un istante… Quando mi hanno detto che sarei diventato padre, non trovai altro da fare che pensare a mio padre. E mi guardai pure allo specchio, non mi vergogno a dirlo, per scoprire che di colpo non somigliavo più né a mio padre né a mia madre.
Ma a mio nonno. Sì, proprio a lui, a quel povero cristo, alto e austero che il padreterno, in un giorno di negligenza, era “sdirupato” su una vallata, a sud della Sicilia, senza alberi senza fichidindia. Un pezzo di Sicilia, incagliato tra gli altipiani degli Iblei e le colline antistanti alla riviera, ma che della Sicilia bedda, quella amata e spupazzata dal cinematografo, non aveva proprio nulla. Nemmeno l’orgoglio di avere dato i natali, si dice così, a Salvatore Quasimodo e al Gian Battista Odierna: che erano certamente persone illustri e in quanto tali potevano essere comodamente liquidati, come i baroni, con una levata di coppola e un “voscenza ‘bbenedica”. Che ne sapevamo noi della letteratura e della matematica, della storia e dei miti, delle verità e degli inganni che avevano attraversato la Sicilia? Certo, la sera, se tu bambino non fossi riuscito proprio a dormire, avresti trovato pur sempre un nonno, un padre, uno zio o comunque un sant’uomo disposto a prenderti sulle ginocchia e a rassicurarti.
Ma le favole, le nostre favole, non avevano né la semplicità della parola né la lucentezza del racconto. Erano per lo più trame impastate di “pane e tumazzu”, di sottintesi compiaciuti, di ammiccamenti ruffiani, di complicità innocenti e beffarde. Telegrammi immaginari, li avrebbe chiamati Francis Scott Fitzgerald. Ma che ne sapeva, mio nonno, de “Il grande Gatsby” e di tutte le altre diavolerie americane? Una sera – avevo forse sei o sette anni – mio nonno vide che tremavo dalla paura. Gli confessai che la maestra ci aveva parlato dei fantasmi e che, parlando parlando, quel pensiero si era ingrottato, nefasto e serpigno, nella mia mente. Per un pronto accomodo, cambiò discorso. Mi raccontò che lui invece, aveva incontrato banditi e briganti, altro che fantasmi; e che un giorno, lungo la trazzera di Malavita (una località fra Ragusa e Santa Croce Camerina), un nome e un incubo, era stato persino fermato da due picciotti col viso coperto – “infacciolati”, diceva lui – venuti dalla città di Vittoria o giù di lì, ma certamente mandati da quel vicarioto che rispondeva al nome di Salvatore Falcone: sì, proprio lui, il terribile delinquente, il re della mala vita iblea, quello che si era fissato di somigliare a Tyrone Power e che aveva avuto anche il fegato di dettare, prima di morire ammazzato, le poche ma sentite parole da scrivere sulla sua tomba.
Due versi con rima baciata: poveri sogni miei alati e muti, come uccelli di bosco siete caduti. “Vedi, figlio mio, quante avversità e quante male persone? Eppure, sono rimasto sano e pieno di vita”, concludeva. Perché lui, mio nonno, sapeva come allontanare briganti e fantasmi che si avvicinavano alla sua terra della sciumara (terreno vicino al fiume Irminio), terra di pietre e grano duro: bastava andare di notte nel campo di fave, laggiù lungo il fiume, nel feudo della baronessa di Arezzo; bastava camminare quatti quatti lungo i rovi che marcavano il confine, e il sortilegio avrebbe allontanato ogni anima nera. Una premessa ammaliante che, agli occhi di un bambino, inevitabilmente fiammeggiava di eroismo, di epopea misera e gigante: quale piccolo Sancho Panza non avrebbe seguito, altero e mansueto, quel grande Don Chisciotte? Per quasi un’ora camminammo di notte a cavallo di un mulo baio, lui davanti e io in groppa, alla luce di nuvole chiare. Me ne stavo aggrappato, con le mani e con l’unghia, al suo scapolare verdastro; gli occhi sgranati dall’attesa e dal mistero.
Mi veniva da piangere, ma l’avventura non prevedeva né lacrime né singhiozzi. Solo silenzio: perché il rumore avrebbe svegliato i cani e i campieri della baronessa; e a quel
punto, buonanotte ai suonatori. Era anche vietato parlare: “Se il mulo è muto, tu perché parli?”. E così, aqquattati e silenti, ci addentrammo nel campo delle fave. Delle fave verdi, quelle col baccello succoso e vellutato. Le cogliemmo a manate. “Mangia, figghiumiu, ché i fantasmi se ne vanno”. “Anche i briganti?”. “Anche i briganti”. E appanzati come non mai, tornammo a riprendere il mulo. Potrò mai raccontare una favola così – tenera e scellerata – a mia figlia, nata a Comiso (città di Bufalino e di Salvatore Fiume…), e che, per una civetteria del destino, porta lo stesso nome della figlia del mio mito storico Giulio Cesare “Giulia”? Cinquanta e passa anni fa, la notte in cui sazi e stregati tornammo dal campo di fave – era stata una notte di insonnia ribalda e ghibellina – ricordo che mi addormentai serenamente, con la dolcezza dell’infanzia, senza sussulti e senza paure. Mi rassicurava la memoria di un odore – l’odore dello scapolare verdastro – e di una epopea che, come nell’Ulysses, aveva incrostato di una “scorza salina” la vecchiaia di mio nonno. E me lo conservava giovane come un’anguilla, iridato di squame e di mare, forte e bello come tutti gli eroi. Quale epopea, quali fantasmi, quali odori potrò mai condividere io con mia figlia?
L’altro ieri, era di maggio, ho comprato al mercato un sacco bello di fave, ce n’erano a quintalate sui banconi del Mercato del mercoledì a Ragusa. Mi rosicchiava dentro un filino di nostalgia e, arzillo come non mai, l’ho portato a casa, pronto per chissà quale orgiastico rito della memoria. Ma non ho invitato, al banchetto, la mia unica figlia perché sta studiando all’università di Bologna… e sentendola stava già degustando le piadine romagnole… come siamo distanti anni luce con la Giulia… ma l’amore per la nostra terra è viva in Lei come in me, e ciò mi rallegra il cuore come quella sera in cui mangiai le fave della baronessa
Salvatore Battaglia Presidente dell’Accademia delle Prefi
Cultura
Da Pantelleria a Parigi Francesco Belvisi porta la stampa 3D leggera nella nautica. Novità assoluta alla Jec World 2026

Combinando manifattura robotizzata, progettazione strutturale leggera, materiali riciclabili e flussi produttivi digitali, NUGAE apre la strada a una nuova generazione di soluzioni per la cantieristica nautica più veloci, più leggere e più sostenibili
NUGAE introduce un nuovo paradigma per la stampa 3D di grande formato nella nautica a JEC World 2026 Parigi, JEC World 2026 — La deep-tech company italiana NUGAE presenta un’importante innovazione nella manifattura additiva di grande formato applicata al settore nautico, mostrando un componente strutturale che dimostra come la stampa 3D robotizzata possa trasformare il modo in cui imbarcazioni e grandi strutture in composito vengono progettate e realizzate.
Al centro dell’innovazione vi è UL-LFAM (Ultra-Light Large Format Additive Manufacturing), un sistema proprietario di produzione robotizzata sviluppato da NUGAE che consente la realizzazione di strutture di grandi dimensioni estremamente leggere con livelli di efficienza senza precedenti. A differenza dei processi tradizionali della cantieristica nautica, che richiedono stampi complessi e lavorazioni laboriose, il sistema NUGAE consente di produrre direttamente le geometrie strutturali attraverso processi di manifattura additiva robotizzata.
Questo approccio permette di ridurre in modo significativo peso, tempi di produzione e
sprechi di materiale, ampliando allo stesso tempo la libertà progettuale.
Il componente presentato a JEC World 2026 (Hall 5 – E148) rappresenta un esempio
emblematico di questa filosofia: un grande elemento strutturale che pesa solo 37 kg,
realizzato in 72 ore di stampa, utilizzando il 70% di materiale riciclato.
Il progetto presentato a JEC è sviluppato da NUGAE nell’ambito del progetto NEMO –
Design 4 Yacht Flexible Customization, realizzato in collaborazione con Politecnico di
Milano. L’elemento esposto in fiera fa parte di un catamarano di 43 piedi attualmente in
costruzione da parte di NUGAE.
Il sistema si basa su un ecosistema tecnologico proprietario sviluppato da NUGAE. Il primo elemento è la piattaforma robotizzata di stampa 3D di grande formato, progettata per produrre gusci strutturali complessi e componenti di grandi dimensioni destinati al settore nautico e ad altre applicazioni industriali. Il secondo elemento chiave è CoreLight3D®, un innovativo materiale core ultraleggero a base di polipropilene riciclato (PP). Sviluppato da NUGAE specificamente per la manifattura additiva robotizzata, il materiale è progettato per essere facilmente lavorabile mantenendo capacità di adesione con resine e compositi. Il terzo elemento è NU-Slice, il software proprietario sviluppato da NUGAE che gestisce il funzionamento del sistema robotizzato e implementa strategie avanzate di slicing e deposizione del materiale.
Insieme, queste tecnologie permettono la produzione di strutture a guscio leggere con geometrie interne integrate, ridefinendo il modo in cui grandi componenti possono essere progettati e realizzati.
La tecnologia è già operativa in contesti industriali ed è applicata a strutture nautiche, componenti di design e altri ambiti della manifattura avanzata. Sebbene il settore nautico rimanga il principale ambito di specializzazione dell’azienda — nel quale NUGAE mantiene una specificità che la rende probabilmente un caso unico a livello mondiale — la società sta esplorando anche altri settori industriali attraverso collaborazioni che verranno annunciate a breve. “Il nostro approccio è sempre stato guidato da un principio molto chiaro: leggerezza e ottimizzazione dei processi”, afferma Francesco Belvisi, Co-Founder di NUGAE. “Progettiamo componenti strutturalmente efficienti che non richiedono lavorazioni di post- processing onerose. L’obiettivo è ottenere pezzi che escono dalla stampante già pronti all’uso, riducendo tempi, sprechi e complessità lungo tutta la filiera produttiva.”
Combinando manifattura robotizzata, progettazione strutturale leggera, materiali riciclabili e flussi produttivi digitali, NUGAE apre la strada a una nuova generazione di soluzioni per la cantieristica nautica più veloci, più leggere e più sostenibili.
www.nugae.tech
Seguici sul nostro canale WhatsApp
Cultura
Pietro Gabriele porta il suo progetto di successo da Pantelleria alle Pelagie e crea “Lampedusa Interattiva”

“Lampedusa Interattiva”: Pietro Gabriele presenta il nuovo ecosistema digitale dell’isola. Il digitale non come semplice vetrina, ma come infrastruttura utile
Il 4 marzo, il pantesco Pietro Gabriele ha presentato a Lampedusa il nuovo portale turistico e la nuova applicazione mobile dedicati all’isola: un ecosistema digitale pensato per valorizzare il territorio, migliorare l’accesso alle informazioni e creare un collegamento diretto tra turisti, imprese locali e comunità.
Il progetto nasce sull’onda del successo di Pantelleria Experience, l’app innovativa sviluppata da Pietro Gabriele negli ultimi anni, pensata per accompagnare i visitatori nella scoperta dell’isola attraverso strumenti pratici, contenuti geolocalizzati, informazioni utili e nuove modalità di interazione con il territorio. Dopo un lungo percorso di sviluppo, test e perfezionamento, quel modello è oggi pronto a uscire dai confini di Pantelleria per iniziare un nuovo cammino.
Grazie all’interesse e alla collaborazione con il tour operator Nagi Tour e con We Love Lampedusa, la pagina Instagram più seguita dell’isola e tra le più forti del panorama siciliano, il progetto è stato portato all’attenzione del Comune di Lampedusa e dell’AST, gestore dell’aeroporto. Un passaggio importante, che segna l’inizio concreto di una nuova fase.
Abbiamo intervistato Pietro Gabriele
In cosa consiste il progetto?
“Si tratta di un vero e proprio ecosistema digitale dell’isola. Non solo un’app, ma un insieme di strumenti pensati per semplificare la vita ai turisti e, allo stesso tempo, dare più valore alle attività locali. L’idea è quella di riunire in un unico spazio informazioni utili, servizi, attività, esperienze, strutture ricettive, noleggi, ristoranti, aggiornamenti e strumenti interattivi, così da rendere il soggiorno più semplice, più organizzato e anche più coinvolgente.
“Dopo quattro anni di test, sviluppo e lavoro sul campo con Pantelleria Experience, è arrivato il momento di espandere questo progetto. Il mio sogno è quello di far comunicare tutte le isole attraverso questo sistema e creare una rete comune di collaborazione.
“Le isole italiane sono spesso lasciate sole, costrette ad affrontare da sé problemi strutturali, collegamenti difficili, servizi frammentati e una comunicazione che troppo spesso non riesce a restituire davvero il valore del territorio. Progetti come questi possono aiutare non solo a valorizzarle, ma anche a renderle più forti, più connesse, più capaci di raccontarsi e di organizzare meglio la propria offerta.
Credo che la tecnologia, se usata bene, possa diventare uno strumento concreto per dare più opportunità ai territori insulari e per far sì che il turismo non resti qualcosa di superficiale, ma diventi sviluppo reale, visibilità, collaborazione e crescita condivisa. Credo che questo, a Pantelleria, nelle ultime 3 stagioni è stato ampiamente dimostrato.”
Com’è andata a Lampedusa?
“Lampedusa è un’isola che ha molte cose in comune con Pantelleria, soprattutto per quanto riguarda alcune problematiche del territorio e il tema dei collegamenti. Al contrario di Pantelleria, però, ha molte più presenze turistiche e una tipologia di visitatore completamente diversa.
“Qui non c’è tanto il problema di far arrivare la gente, quanto piuttosto quello di riuscire a orientarla bene, a offrire informazioni chiare, a valorizzare in modo ordinato il territorio e a mettere realmente in rete le attività dell’isola. Anche Lampedusa, come Pantelleria, ha bisogno di strumenti che aiutino a ottimizzare la comunicazione, semplificare l’esperienza del turista e dare più forza alle realtà locali.
“Ho trovato un territorio molto vivo, con un grande potenziale, ma anche con un bisogno concreto di fare sistema. Ed è proprio lì che un progetto del genere può fare la differenza.”
Che risposta hai avuto dal territorio?
“I lampedusani sono persone molto protettive nei confronti della loro isola, ma in realtà questa è una caratteristica che accomuna anche noi panteschi. Forse anche per questo mi sono sentito subito a mio agio. Sarà che anche io sono un orgoglioso isolano, ma ho trovato un territorio molto aperto, interessato e pronto a sostenere il progetto.
“Il Comune di Lampedusa mi ha aperto le sue porte e l’assessore al turismo Laura Casano ha espresso parole di entusiasmo durante la presentazione. Anche l’AST di Lampedusa mi ha accolto con grande disponibilità, arrivando a proporre una postazione di accoglienza direttamente agli arrivi dell’aerostazione per promuovere e far conoscere l’applicazione ai visitatori.
“Insomma, oltre al territorio, ho trovato enti pronti a sostenere il progetto. Per me questo è motivo di orgoglio, perché troppo spesso, al contrario, sulla nostra isola non viene dato il giusto credito ai progetti realizzati dagli stessi isolani. Si preferiscono spesso idee presentate da aziende esterne, confezionate bene sulla carta, ma che poi restano fini a se stessi e che, nella realtà, all’isola non portano nulla.
“Io credo invece che quando un progetto nasce da chi vive davvero il territorio, da chi conosce i problemi, i tempi, i limiti e anche la bellezza autentica di un’isola, allora quel progetto abbia molte più possibilità di essere utile davvero. Spero che in futuro si possa fare più attenzione.”
Un progetto che guarda oltre
La presentazione del nuovo ecosistema digitale di Lampedusa segna un passaggio importante non solo per l’isola, ma per una visione più ampia che guarda al futuro dei territori insulari italiani.
L’idea di fondo è chiara: usare il digitale non come semplice vetrina, ma come infrastruttura utile, concreta e capace di creare connessioni reali tra persone, imprese e luoghi.
Con Pantelleria Experience prima e con questa nuova espansione oggi, Pietro Gabriele porta avanti una visione che parte dall’identità isolana e prova a trasformarla in innovazione, collaborazione e opportunità.
Una rete tra isole, costruita da chi le conosce da dentro, potrebbe essere davvero l’inizio di un nuovo modo di pensare il turismo e la valorizzazione del territorio.
Aggiornati con il nostro canale WhatsApp
Ambiente
Pantelleria, le guide del Parco impegnate nell’affascinante corso di formazione in Astrobiologia

Ecco cosa sta accadendo al Lago di Venere
Al via il Corso di Formazione in Astrobiologia per le Guide del Parco
Nazionale di Pantelleria
Con al centro il Bagno dell’Acqua, laboratorio naturale per lo studio di ambienti estremi e delle possibili tracce di vita oltre la Terra
Ha preso avvio sabato 7 marzo 2026 un Corso informativo sull’Astrobiologia rivolto alle Guide ufficiali dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria. L’iniziativa, valutata e approvata dal Commissario Straordinario del Parco Italo Cucci ,nasce alla luce delle recenti scoperte scientifiche riguardanti il Lago Bagno dell’Acqua, un ambiente naturale caratterizzato da peculiari condizioni geologiche e geochimiche che lo rendono un importante “analogo astrobiologico”.
Contesti di questo tipo rappresentano infatti modelli naturali di grande interesse per la comunità scientifica internazionale, utili per comprendere processi, strutture e possibili tracce che potrebbero essere presenti (allo stato fossile o come possibili forme di vita microbica) su altri pianeti e satelliti del Sistema Solare, come Marte o le lune ghiacciate di Giove e Saturno. Il corso è coordinato dalla prof.ssa Barbara Cavalazzi, docente di Paleontologia presso l’Università di Bologna e studiosa impegnata da anni nel campo dell’astrobiologia e dello studio degli ambienti estremi come analoghi di ecosistemi extraterrestri.
L’obiettivo dell’iniziativa è fornire alle guide del Parco strumenti scientifici aggiornati per interpretare e comunicare al pubblico il valore di questo particolare contesto naturale, inserendolo nel più ampio quadro della ricerca astrobiologica internazionale. Alle attività didattiche partecipano docenti e ricercatori provenienti da diverse istituzioni accademiche e di ricerca: Luigi Zucconi e Fabiana Canini dell’Università della Tuscia, Monica Pondrelli dell’Università di Chieti-Pescara, Federico Lucchi dell’Università di Bologna, e Govannella Pecoraino dell’INGV – Sezione di Palermo.
Il progetto si inserisce nelle attività scientifiche del progetto HELENA – Habitat Estremi di Laghi vulcanici per l’Esplorazione Astrobiologica, che vede Pantelleria con il Lago Bagno dell’Acqua un laboratorio naturale per lo studio di ambienti estremi e delle possibili tracce di vita oltre la Terra. Al termine del corso saranno organizzati incontri aperti alla cittadinanza a Pantelleria, dedicati alla divulgazione scientifica e alla valorizzazione di uno degli aspetti più intriganti e appassionanti del patrimonio naturalistico dell’Isola che l’Ente Parco è chiamato a tutelare e promuovere.
Resta aggiornato con il nostro canale WhatsApp
-

 Ambiente5 anni fa
Ambiente5 anni faAMP, a Pantelleria Insieme Live: zonizzazioni e Guardia Costa ausiliario. Gadir e il brillamento de Il Caldo
-

 Personaggi4 anni fa
Personaggi4 anni faStasera 4 Ristoranti a Pantelleria, con Alessandro Borghese. Ecco chi sono
-

 Ambiente4 anni fa
Ambiente4 anni faPantelleria, il PD segnala colorazione anomala e artificiale nella spiaggia del Lago di Venere
-

 Pantelleria4 anni fa
Pantelleria4 anni faPantelleria a lutto per Giovanni Maddalena, il galantuomo del Conitro
-

 Personaggi4 anni fa
Personaggi4 anni faPantelleria, è U Runcune il vincitore di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese
-

 Cronaca4 anni fa
Cronaca4 anni faUltima Ora – Pantelleria. Identificata la donna morta per annegamento, il secondo suicidio in un mese
-

 Capitaneria di Porto4 anni fa
Capitaneria di Porto4 anni faPantelleria, allarmanti condizioni meteo-marine nelle prossime 48/72 ore: onde 6 da metri
-

 Pantelleria4 anni fa
Pantelleria4 anni faPantelleria, divieto di balneazione a Punta San Leonardo