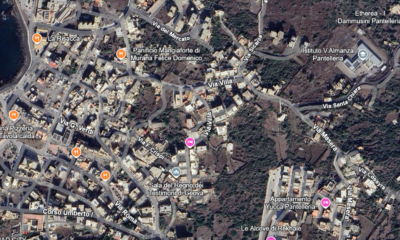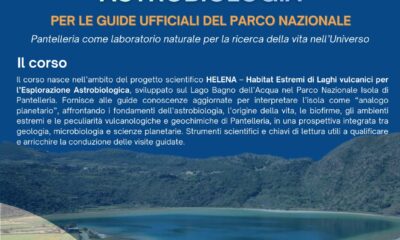Le due pregiate teste di terracotta sequestrate dalla Guardia di Finanza in Sicilia sono uniche nel loro genere. Si tratta di due manufatti in terracotta plasmata a mano, e sono solo la parte superstite di due tegole a sezione triangolare. Erano chiuse da antefisse a maschere antropomorfe, di dimensioni naturali, raffiguranti i volti di un uomo e di una donna, entrambi giovani.
Le due tegole, secondo quanto ricostruito dagli esperti, appartengono al tipo del Kalypter egemon, caratteristico delle falde di copertura di un edificio sacro o di carattere funerario, che in questo caso sarà stato di piccole dimensioni. I due volti non hanno carattere ritrattistico e non rivelano alcun elemento che ne caratterizzi la personificazione con figure della religione o del mito. I manufatti sono opera dello stesso artigiano, abile e conoscitore della grande arte a lui contemporanea.
Esempi stilistico delle due teste di terracotta
Il maggiore riferimento stilistico a cui associarle sono le sculture frontonali del Tempio di Zeus, a Olimpia. La figura maschile è assai simile a quella di Apollo del frontone occidentale. Quella femminile, invece, si confronta con il volto della figura femminile distesa. A quest’ultima è accomunata anche dal dettaglio della capigliatura trattenuta da un Sakkòs. Le sculture di Olimpia risalgano alla prima metà del V secolo a.C. e costituiscono l’esempio esponenziale dello stile Severo nell’arte greca. Sono esempio di transizione tra l’artee arcaica (fine VII-inizi V sec. a.C.) e quella classica (metà V-metà IV sec. a.C.).
I due reperti sequestrati, realizzati tra il 480 e il 450 a.C., non hanno però confronti esatti ed è dunque molto difficile stabilire il luogo di produzione e di provenienza.
Opere autentiche
Esami della Soprintendenza e dell’università di Catania hanno confermato l’originalità delle opere. Sono pezzi unici nel panorama noto della storia antica, con un’altissima qualità estetica ed esecutiva, risalenti al 450-480 avanti Cristo.
L’autenticità dei due reperti è stata inoltre confermata dalla metodologia messa a punto presso i laboratori Ph3Dra dell’università di Catania. Il metodo è stato messo a punto da docenti e ricercatori del dipartimento di Fisica e astronomia ‘Ettore Majorana‘, specialisti nel campo dei test di autenticità tramite termoluminescenza, e del dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica per le competenze specifiche nell’ambito delle misure elettriche ed elettroniche. Grazie alla collaborazione tra i due dipartimenti è stato possibile mettere a punto una metodologia innovativa. Grazie a metodi di trasduzione non invasivi, consente di valutare l’autenticità e la compatibilità con l’età presunta di reperti ceramici.
Ipotesi di provenienza
Il tipo di tegola a sezione triangolare è molto raro, rispetto ad esempio a quello a sezione semicilindrica. Ad ogni modo è noto in diversi luoghi, in Grecia soprattutto, tra Corinto, Creta, e le isole dell’Egeo; ma anche nell’Italia centrale, nell’area etrusco-italica. In Sicilia se ne conosce un solo esemplare, da Selinunte. Tuttavia, a parte la tipologia della tegola, nessuno degli esemplari noti riporta un’antefissa paragonabile alle maschere antropomorfe dei reperti sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania.